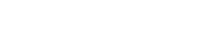Appalti e sicurezza così la prevenzione.
L’ampiezza del quesito non consente una risposta analitica di dettaglio, tenendo presente che il sistema degli appalti -privati ma anche pubblici - costituisce uno dei settori di maggiore criticità funzionale e relazionale, e di più elevata incidenza infortunistica. Si può nondimeno tracciare il quadro normativo di riferimento, cominciando con il riconoscere che il recepimento delle direttive comunitarie ha affiancato alla tradizionale dimensione della sicurezza "intra-aziendale", la nuova dimensione della sicurezza "integrata di cantiere”.
Consulta "Il Punto del giurista" su tutti i temi della sicurezza
Differenti modelli
Si possono così delineare due modelli organizzativi della sicurezza sul lavoro: uno a livello aziendale (per il quale dispone il titolo I del D.Lgs. n. 81/2008), e un secondo nell’ambito più allargato dei cantieri temporanei e mobili (titolo IV, capo I del D.Lgs. n. 81/2008). Ciò determina la fondamentale distinzione tra le seguenti tipologie di rischio:
- i rischi "intra-aziendali", attinenti cioè al profilo specifico dei fattori di rischio propri dell’attività lavorativa svolta da ciascuna impresa esecutrice;
- i rischi interferenziali (o “di cantiere”), dipendenti dalla contemporanea convergenza di più attività di lavoro all’interno dell’area del cantiere, e che perciò necessitano di un efficace coordinamento.
Peraltro, la categoria dei rischi “interferenziali” non può dirsi limitata al cantiere edile o di ingegneria civile; essa invero sussiste anche in ambito aziendale, ogniqualvolta vi sia la contemporanea presenza di distinte organizzazioni di lavoro, una delle quali “ospitante” e rappresentata perciò dal Datore di lavoro “committente” (sul tema, da ultimo, Cass. pen. sez. III, 4 agosto 2021, n. 30308).
Tutto sulla sicurezza? Abbonati ad Ambiente&Sicurezza
La nozione di “appalto” ricomprende poi sia il subappalto, sia il nolo a caldo e di “fornitura e posa in opera” di materiali, tutte accomunate dalla caratteristica dell’impiego necessario di manodopera. [1]
In secondo luogo, non è più requisito essenziale degli appalti/affidamenti di lavori, servizi e forniture, il connotato di loro “internità”: la circostanza che si tratti di appalti “interni” è ora una condizione sufficiente, ma non più indefettibilmente necessaria, giacché gli obblighi posti a carico del committente sono stati estesi anche ai lavori che si svolgono “nell’ambito” dell’intero ciclo produttivo della di lui azienda.
Una necessaria distinzione
Insomma, la distinzione tra committente quale soggetto “ospitante”, e impresa o lavoratore autonomo quali soggetti “ospitati”, si amplia fino a ricomprendere gli appalti di lavori interessanti – in qualunque luogo essi siano svolti - il ciclo produttivo dell’azienda del committente.
Con la legge-delega 3 agosto 2007, n. 123 per l’adozione di un testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il legislatore ebbe a introdurre, in capo al committente, l’obbligo di elaborazione «di un unico documento di valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze» (Duvri), nonché di indicare specificamente, in tutti i contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto del settore privato, i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
Il Duvri e il Psc
Duvri e Psc costituiscono pertanto gli strumenti per l’abbattimento/riduzione al minimo dei rischi interferenziali: nell’ottica del Duvri ciò che rileva è la imprescindibile qualità di datore di lavoro del committente; laddove nel settore dei cantieri edili e di ingegneria civile, il committente può non essere strutturato in forma di impresa (e il fatto che lo sia non è una condizione necessaria), rilevando piuttosto la “tipologia” dei lavori e la loro “localizzazione” in un cantiere (idest: area “cantierabile”).
Resta il fatto che il settore degli appalti, in ambito prevenzionistico, era e resta uno dei settori più critici: non a caso i contratti di appalto che diano luogo a lavori edili o di ingegneria civile da effettuarsi in “aree cantierabili”, sono regolati in via specifica dal titolo IV, capo I del D.Lgs. n. 81/2008 (ex D.Lgs. n. 494/1996), e anche in ambito di legislazione comunitaria hanno una loro specifica direttiva di riferimento (direttiva. 92/57/Cee del 24 giugno 1992).
Ciò che, a partire dagli anni ’90, il nuovo “corso” della sicurezza ha messo in luce, è il venir meno della filosofia operativa e gestionale del "separati in casa" che, in questo ambito, aveva caratterizzato il rapporto tra committente e appaltatore. Mentre in epoca precedente vigeva il divieto assoluto di ingerenza e l’obbligo assoluto di astensione del committente sull’autonomia strutturale e organizzativa dell'appaltatore (o del lavoratore autonomo), via via la giurisprudenza più sensibile (per tutte Cass. pen. sez. IV, 5 luglio 1990, Travaglini) ebbe a rimarcare l’inevitabile coinvolgimento del committente tutte le volte in cui, «considerata l'interdipendenza dei lavori», non potesse essere negata «l'ingerenza del primo sull'attività del secondo».
Il ruolo del committente
È così che da una supposta estraneità “per definizione” dall'area della sicurezza del lavoro, il legislatore ha ritenuto di ricondurre l'obbligo di gestione dei fattori di rischio "interferenziali" nell'area funzionale della committenza: l'unica che avrebbe potuto prenderli su di sé, in ragione della titolarità di un interesse economico alla realizzazione dell'opera, ovvero alla terziarizzazione (parziale) del processo produttivo aziendale.
Costituiva efficace espressione di questa filosofia del “separati in casa” tra committente e appaltatore (impresa e/o lavoratore autonomo) la pronuncia di Cass. pen. sez. IV, 4 marzo 1994, Pieco. Con riguardo al caso di un incarico conferito dal proprietario di un fabbricato al titolare di una impresa edile artigiana, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del tetto e delle grondaie, la suprema Corte ebbe ad affermare che «Nessun dovere di intervento ha il committente che si rivolga a persona capace, in grado di realizzare l'opera, peraltro di modesta entità, con rischi prevedibili ed eludibili con una ordinaria professionalità e diligenza. Neppure è ipotizzabile a carico del committente l'obbligo di segnalazione al lavoratore autonomo dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera, di cui all'art. 5, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, qualora il luogo di lavoro non presenti insidie occulte o pericoli non immediatamente percepibili»; e che «l'imprenditore artigiano è tenuto ad approntare tutte le misure di sicurezza e le cautele che le norme vigenti e il tipo di lavoro impongono, in particolare a provvedere alle impalcature e alle cinture di sicurezza che la legge prescrive in casi in cui vi sia il pericolo di caduta dall'alto». Al contrario, con il modello di lavoro introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 (attuale art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008), la prospettiva è stata tendenzialmente rovesciata.
No alla separazione
Pur restando fermo il principio del divieto di ingerenza del committente nell’area dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (sul tema, da ultimo Cass. pen. sez. IV, 7 ottobre 2022, n. 38033 e Cass. pen. sez. IV, 29 ottobre 2018, n. 49373), si è rinunciato alla rigida separazione funzionale tra committente e appaltatore, ritenendo maturi i tempi per imporre, nel variegato settore dell'appalto, un modello sinergico e di collaborazione partecipata tra i protagonisti, reso effettivo dalla previsione di molteplici doveri di attivazione positiva (informazione, cooperazione e coordinamento). Si è ritenuto, insomma, che tanto l’informazione preliminare sui rischi ambientali, quanto la cooperazione e il coordinamento gestional-operativi nell’ambiente di lavoro, fossero strumenti in grado di offrire un valore aggiunto e un risultato di sintesi, in termini di salvaguardia della sicurezza e della salute, superiore alla somma di quelli ottenibili da ciascun singolo datore di lavoro.
E proprio nell’aver voluto e saputo valorizzare - codificandoli normativamente - gli aspetti di naturale e spontanea collaborazione che si realizzano quando più persone sono chiamate a prestare la loro opera nello stesso ambiente di lavoro, prima il D.Lgs. n. 626/1994, e poi il D.Lgs. n. 81/2008 hanno abbandonato i concetti di "divieto assoluto di ingerenza" e di "obbligo assoluto di astensione" del committente/appaltante sull’autonomia strutturale e organizzativa dell'appaltatore, divenuti ormai, con riguardo agli appalti interni all’impresa, largamente inadeguati in termini di efficace tutela delle condizioni di lavoro.
Atteso che l’interferenza tra le lavorazioni, sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro e strutturale, è un dato ontologico spesso ineliminabile, il legislatore ha imposto la triplice azione di “informazione”, "cooperazione" e "coordinamento" comuni.
Beninteso, è stata correttamente mantenuta la distinzione concettuale tra i profili di "rischio ambientale" e i profili di "rischio specifico"; ma solo come estremi, e come situazioni-limite all'interno di un modello all'opposto tutto incentrato sulla condivisione in senso collaborativo - a fine di maggior tutela di ciascuno - dei profili di rischio tra committente e singoli appaltatori e subappaltatori.
Il nodo dell’interferenza
L’interferenza tra imprese esecutrici (e/o lavoratori autonomi) trova dunque la sua sede primigenia e naturale nell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008: e sebbene il comma 2, lett. b) di questa norma parli di «rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva», scorrendo il testo dell’omologa previsione contenuta nella direttiva comunitaria 92/57/Cee (art. 6, paragrafo 1, lett. d)), che a sua volta richiama l’art. 6, paragrafo 4, della direttiva-quadro 89/391/Cee, vedere la tabella 1), si ricava inequivocabilmente che le interferenze riguardano le lavorazioni a condizione che siano svolte da imprese (e/o lavoratori autonomi) diversi («quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese»): il che significa che le interferenze “interne” alla realtà di ciascuna impresa non entrano nella logica di pianificazione della sicurezza e gestionale del Duvri. Su questo specifico punto la Cassazione ha correttamente puntualizzato (Cass pen. sez. IV, 9 settembre 2015 n. 36474) che il Duvri «concerne rischi che derivano dalla presenza di imprese diverse (rischio interferenziale in senso proprio) e non già il rischio connesso allo svolgimento di lavorazioni distinte da parte della medesima impresa, da governarsi nello specifico attraverso il Pos».
TAB 1 – IL QUADRO EUROPEO
| Direttiva 92/57/Cee | Dir 89/391/Cee |
| Articolo 6 - Realizzazione dell'opera: compiti dei coordinatori. «Durante la realizzazione dell'opera, il o i coordinatori in materia di sicurezza e di salute designati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1:
(omissis) d) organizzano tra i datori di lavoro, compresi quelli che si succedono nei cantieri, la cooperazione ed il coordinamento delle attività in vista della protezione dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali nocivi alla salute, nonché la loro reciproca informazione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 89/391/Cee integrandovi, se necessario, i lavoratori autonomi». |
6. Obblighi generali dei datori di lavoro.
(omissis) 4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti. |
Nella nozione di “interferenza” rientra non solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche la mera coesistenza, in un medesimo contesto, di più organizzazioni di lavoro (tra le tante, Cass. pen. sez. III, 12 ottobre 2022, n. 38357 e Cass. pen. sez. IV, 9 luglio 2019, n. 29919).
Quanto all’obbligo, gravante sul committente, di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro (art. 26, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008), trova il suo presupposto applicativo nella circostanza che il datore di lavoro abbia affidato lavori o servizi a soggetti terzi (imprese o lavoratori autonomi) «all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto». La ratio della norma è evidente: solo la disponibilità effettiva, nel senso di disponibilità giuridico/operativa, dei luoghi in cui si svolgono i lavori consente al datore di lavoro/committente di avere (o comunque di essere tenuto ad avere) compiuta conoscenza delle specifiche caratteristiche degli stessi e quindi dei rischi ad essi connessi. Di talchè le informazioni non potrebbero essere fornite da un soggetto che non abbia conoscenza dei luoghi, per mancanza di un effettivo legame giuridico/operativo con l'ambiente di lavoro (Cass. pen. sez. IV, 9 agosto 2022, n. 30809; Cass. pen. sez. IV, 20 luglio 2022 n. 28444; Cass. pen. sez. IV, 23 ottobre 2020, n. 29442; Cass. pen. sez. IV, 29 ottobre 2018, n. 49373).
Il coordinamento e la cooperazione
La Cassazione ha altresì rimarcato che, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, valutati nella relazione tra le imprese ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica (nomen iuris) attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che questo rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte: di talché gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito della rispettiva responsabilità (da ultimo, Cass. pen. sez. IV, 14 marzo 2022, n. 8468 e Cass. pen. sez. IV, 12 settembre 2019, n. 37776).
Quanto all’obbligo del committente di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati in appalto non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che è un adempimento di carattere amministrativo (così da ultimo Cass. pen. sez. IV, 9 agosto 2022, n. 30803).
Le omissioni
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che il committente risponde di tutte le omissioni prevenzionistiche connesse alla mancata adozione immediatamente percepibile delle misure di prevenzione prescritte (Cass. pen. sez. IV, 17 novembre 2016, n. 48826; Cass. pen. sez. IV, 23 gennaio 2008, n. 3502; Cass. pen. sez. IV, 19 settembre 2006, n. 30857), giacché nella categoria dei cosiddetti “rischi specifici” propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, rientrano solo le lavorazioni che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale, nonché la conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni, o l'utilizzazione di speciali tecniche, o ancora l'uso di determinate macchine e attrezzature di lavoro (Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2020, n. 26132; Cass. pen., sez. IV, 26 settembre 2016, n. 39828; Cass. pen. sez. IV, 20 marzo 2008, n. 12348; Cass. pen. sez. IV, 19 agosto 2005, n. 31296). Per una pronuncia particolare ma assolutamente condivisibile, che ha ritenuto il rischio di caduta dall’alto come rischio “specifico” dell’impresa esecutrice, si veda la pronuncia di Cass. pen. sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3288. Successivamente questa rinnovata impostazione, segnatamente nei rapporti tra il titolo I e il titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, è stata confermata anche dalla pronuncia di Cass. pen. sez. IV, 13 gennaio 2020, n. 699).
Per tutti i rischi non riferibili alle interferenze, «resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta” (Circ. minLavoro n. 24/2007).
La giurisprudenza (per tutte Cass. pen. sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31459 e Cass. pen. sez. III, 12 maggio 2006, n. 16291) ha poi chiarito da tempo che il Committente è tenuto a fornire le "dettagliate informazioni" sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, ogni qualvolta affidi uno specifico lavoro all’appaltatore, a nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza.
Coordinare significa poi (Cass. n. 31459/2002 cit. e Cass. pen. sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197) «collegare razionalmente le varie fasi dell’attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente»; mentre cooperare «è qualcosa di più, perché vuol dire contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre e applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie». Sotto questo aspetto, la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore. Ne consegue che l'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte a eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno a incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.
Per l’affermazione che l'obbligo di redazione del Duvri è un reato “proprio” in quanto grava sul datore di lavoro committente, cioè esclusivamente «su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo», si rimanda alla pronuncia di Cass. pen. sez. IV, 2 agosto 2022 n. 30397 e di Cass pen. sez. III, 13 febbraio 2023, n. 5907.
Quanto all’ipotesi che la redazione del Duvri possa essere oggetto di “delega” da parte del datore di lavoro committente, si rimanda alla condivisibile pronuncia di Cass. pen. sez. IV, 15 settembre 2021, n. 34103.
Gli appalti “interni”
Nella realtà di cantiere il modello dei cosiddetti “appalti interni” delineato all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ha subito un’esplosione strutturale, sebbene il legislatore abbia mantenuto fermo il divieto per il committente di ingerirsi nelle aree di rischio specifico proprie di ciascuna impresa esecutrice o lavoratore autonomo. Nondimeno, l’area cantierabile rivela una prerogativa ontologica irrinunciabile: quella di essere un luogo destinato alla sinergia e alla compartecipazione promiscua tra distinte organizzazioni di lavoro (imprese e lavoratori autonomi), tutte direttamente investite, seppur a vario titolo negoziale e operativo, delle problematiche attinenti alla sicurezza e alla salute durante la fase sia di progettazione, sia di esecuzione dei lavori destinati alla realizzazione dell’opera edile o di ingegneria civile.
Nell’abito di questa ”area cantierabile”, il legislatore, avendo quale base normativa di riferimento delle rispettive relazioni giuridicamente rilevanti, il contratto di appalto, di subappalto e di fornitura, ha individuato alcuni soggetti (committente o responsabile dei lavori, coordinatori, imprese affidatarie e imprese esecutrici, lavoratori autonomi), qualificandoli come titolari, ciascuno in via autonoma, di una specifica posizione di garanzia ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è stata sanzionata penalmente sia sul piano (anticipato) contravvenzionale, sia in termini di «omesso impedimento dell’evento» secondo il noto paradigma dell’art. 40 capoverso del codice penale.
Sebbene il legislatore non lo abbia evidenziato a chiare lettere, la recente giurisprudenza ha chiarito – sia pure a passi brevi - che l’azione e la posizione di garanzia dei coordinatori (in particolare del Cse) non investe (se si eccettua il potere-dovere di sospensione cautelare) i rischi intra-aziendali specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei singoli lavoratori autonomi (al pari di quanto è da sempre esplicitato ex lege in tema di appalti “interni”).
Conclusione
Il sistema degli appalti, disciplinato nel testo unico della sicurezza sul lavoro, seppur a esito dei numerosi interventi di integrazione e modifica, da ultimo operati dal D.Lgs. n. 106/2009, ha mantenuto l’assetto originariamente delineato nell’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 e nella Direttiva 92/57/Cee.
In verità, l’assetto di base dell’appalto “sicuro” deriva dalla previsione dell'art. 6, paragrafo 4 della direttiva-quadro 89/391/Cee già citata («Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti»), cosicché assumono importanza strategica gli aspetti legati all’organizzazione del lavoro e alla predisposizione di idonei flussi informativi.
Per un’interessante pronuncia che riassume la fisionomia e i contenuti tipici degli obblighi previsti dall’art. 26 del D.L.gs. n. 81/2008, si rimanda alla pronuncia di Cass. pen. sez. IV, 20 settembre 2019, n. 38845.
(1) In tal senso, Cass. pen. sez. III, 28 gennaio 2004, n. 2946, imp. Pallotta e altro.