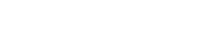Rifiuti inerti e test di cessione: come si prepara il campione da analizzare? Questa, in estrema sintesi, la domanda che Confindustria Alto Adriatico ha rivolto, sotto forma di interpello ambientale, al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
In particolare, secondo l'associazione, la procedura di riduzione dimensionale del materiale da analizzare determinerebbe la formazione di quantità non trascurabili di frazioni fini in grado di poter alterare significativamente la distribuzione granulometrica del campione originale e di conseguenza il suo comportamento al test di lisciviazione. Sebbene questa possibile alterazione della rappresentatività del campione sia riconosciuta anche dalla norma a, non viene tuttavia dettagliata in essa nessuna metodica standardizzata e specifica da seguire per la ricostruzione del campione a valle della macinazione, ma la citata norma si limita ad indicare solamente che «in nessun caso si deve macinare finemente il materiale».
Clicca qui per altri pareri del Mase
Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.
Interpello ambientale di Confindustria Alto Adriatico 10 aprile 2024, n. 67714
Oggetto: Istanza di interpello ex art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, sull'applicazione del paragrafo d), d. 2 dell'Allegato 1 del DM 27.09.2022 n.152.
La scrivente sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, reso necessario a seguito degli approfondimenti awenuti in queste settimane con le Aziende associate che operano nel settore della gestione rifiuti inerti e con i laboratori di analisi accreditati.
Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) numero 152 del 27 settembre 2022, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.lgs. 152/2006.
Nell'Allegato 1, paragrafo d) "d.2) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato - Test di cessione su/l'aggregato recuperato" si prevede che "Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2" onde valutare l'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.
Nell'applicazione pratica accade che taluno segua pedissequamente il contenuto letterale delle disposizioni sul test di cessione previsto dalla norma UNI EN 12457-2 che, come è noto, riguarda la procedura per la caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Un tanto sembra non soddisfare l'obiettivo della norma della legge che mira al riutilizzo dell'aggregato anche di granulometrie maggiori a quelle previste dalla metodica UNI citata; tanto più che gli obiettivi presenti nell'agenda 2030 sono tutti orientati ad incentivare i recuperi e riutilizzi dei rifiuti, aventi caratteristiche adeguate al destino d'impiego.
Infatti, l'applicazione letterale della UNI EN 12457 - 2 presenta diverse problematiche tecniche, tra cui la metodologia di esecuzione dei test e la preparazione dei campioni. Tale norma si applica ai rifiuti granulari e fanghi, e definisce il metodo di esecuzione del test di lisciviazione prevedendo lo svolgimento dello stesso con una frazione granulometrica minore di 4 mm. Qualora il materiale presenti dimensioni superiori ai 4 mm con una percentuale maggiore del 5% in peso, è prevista una macinazione per la riduzione delle dimensioni, caso largamente riscontrabile per i campioni di aggregato recuperato che può presentarsi in un range da 0 a 80 mm.
La riduzione dimensionale dei campioni granulari alle dimensioni indicate provoca la formazione di quantità non trascurabili di frazione fine in grado di alterare significativamente la distribuzione granulometrica del campione e di conseguenza il suo comportamento alla lisciviazione.
Il test di cessione nella norma citata è il medesimo riportato anche nel Decreto 5 febbraio 1998, che disciplina l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, e quindi è applicata a tutti i rifiuti indistintamente.
Una gestione incontrollata e non standardizzata della frazione generata dalla frantumazione degli inerti da costruzione e demolizione può comportare la formazione di una porzione di prova con granulometria significativamente diversa da quella del materiale in origine e fortemente influenzata dalle modalità con cui viene condotta l'operazione di macinazione dal singolo laboratorio, con conseguente elevata variabilità degli esiti della prova.
Questo fenomeno indesiderato è esplicitamente riconosciuto dalla UNI EN 12457-2, la quale tuttavia, anche per la sua applicabilità trasversale ad un'ampia gamma di rifiuti granulari e fanghi, si astiene dal dettagliare una metodica specifica per la ricostituzione della porzione di prova a valle della eventuale macinazione, e si limita ad indicare che "in nessun caso si deve macinare finemente il materiale".
Dunque, l'applicazione letterale della metodica UNI EN 12457 - 2 all'aggregato recuperato potrebbe comportare un'impossibilità di riutilizzo degli inerti da demolizione e costruzione con conseguente destinazione degli stessi a discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi.
Giova inoltre ricordare che le norme tecniche per la certificazione CE riportate nella Tabella 4 del Decreto 152/22 già impongono delle determinate curve granulometriche e delle portanze che il materiale deve rispettare per l'uso specifico al quale sono destinate ed escludono, quindi, il materiale che non rispetta le caratteristiche tecniche utili all'uso, quali materiali che si "sfaldano" e che si frantumano. Non si ravvisa quindi la necessità di esasperare il test di cessione includendo la polvere che si origina dalla macinazione della frazione superiore ai 4 mm prevista dalla norma UNI EN 12457-2.
In tale contesto si propone quindi di scartare la frazione fine che si genera artificiosamente dalla macinazione del materiale di prova almeno per le frazioni riconducibili a sabbia, limo e argille, con granulometria inferiore a 500 um.
Va pertanto ricercata una diversa metodica che pur rientri in un'interpretazione orientata a soddisfare l'obiettivo del riutilizzo.
Nello specifico si potrebbe fare riferimento alla comune pratica di applicazione della UNI/PdR 94:2020. Questa, infatti, in conformità a quanto stabilito in via generale dalla UNI EN 12457-2 per i rifiuti granulari, definisce una metodica specifica applicabile alla scoria nera EAF (Electric Arc Furnace) per la preparazione del campione di prova, con particolare riferimento alle modalità di gestione della frazione generata dalla frantumazione. In particolare, la presente metodica consente l'ottenimento di un campione di prova dalla granulometria ripetibile e rappresentativa ed in tal modo permette di ridurre la variabilità degli esiti della prova, grazie all'utilizzo di diversi setacci e la ricostruzione del campione con le percentuali di setacciato.
Peraltro, potrebbe anche considerarsi la norma UNI EN 1744-3:2003, citata nella norma UNI EN 13242:2008 per la certificazione CE degli aggregati per materiali non legati. La norma, similmente alla UNI/PdR 94:2020, si applica ad aggregati con granuli minori di 32 mm con o senza riduzione di dimensione. La frazione maggiore di 32 mm subisce frantumazione e la norma prevede la selezione della frazione 16-32 mm proveniente da macinazione scartando la parte inferiore a 16 mm. Successivamente viene ricostruito il campione utilizzando la frazione iniziale inferiore a 32mm e la frazione macinata compresa tra 16 e 32, che vengono unite assieme mantenendo lo stesso rapporto percentuale iniziale delle due frazioni. La metodica, attraverso una gestione standardizzata della frazione di materiale risultante dalla frantumazione, consente l'ottenimento di un campione di prova dalla granulometria ripetibile e rappresentativa delle caratteristiche del campione di laboratorio originario e permette in tal modo di ridurre la variabilità degli esiti della prova.
Il metodo prevede un test di dilavamento per 24 ore utilizzando un agitatore meccanico ad immersione invece che impiegando l'utilizzo di un miscelatore a rovesciamento riportato nella norma UNI EN 12457-2.
Tutto ciò premesso si interpella codesto MASE per chiedere se sia ammesso interpretare il rinvio alla "metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2" di cui al paragrafo d), d.2
dell'Allegato 1 del DM 27.09.2022 n. 152, nel senso che in essa rientrino anche le procedure delle sopra citate UNI/PR 94:2020 e UNI EN 1744-3:2003, nei casi di materiali con granulometria maggiore.
Una siffatta "lettura" faciliterebbe il raggiungimento degli obiettivi Europei orientati ad incentivare il recupero.
***
Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, n. 114856
Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 promosso da Confindustria Alto Adriatico (Rif. nota n. 67714 del 10 aprile 2024) - Riscontro.
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/06 l'Associazione di categoria Confindustria Alto Adriatico ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla esecuzione del test di cessione sull'aggregato di inerti recuperato e sulle modalità di applicazione della norma UNI EN 12457-2 - come individuata dal paragrafo d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato, punto d.2) Test di cessione sull’aggregato recuperato - dell'allegato 1 al DM 27.09.2022 n. 152.
Più nel dettaglio, nel documento inviato dall'associazione si fa riferimento ad alcune problematiche tecniche manifestate dagli operatori del settore del riciclaggio dei rifiuti inerti relativamente all'applicazione della metodologia di esecuzione del test di cessione ed in particolare nella preparazione del campione da sottoporre ad analisi.
La associazione rappresenta che la norma UNI 12547-2, che descrive la procedura per la caratterizzazione dei rifiuti granulari e di fanghi mediante prova di conformità alla lisciviazione, come indicato nel decreto ministeriale 152/2022, prevede lo svolgimento della citata caratterizzazione analitica utilizzando una frazione granulometrica minore di 4 mm. La medesima norma prevede, qualora la frazione granulometrica del materiale da testare presenti dimensioni superiori alla soglia dimensionale dei 4mm -condizione quest'ultima largamente riscontrabile per i campioni di aggregato recuperato che possono presentarsi con range di granulometrie comprese tra (I e 80mm - di procedere ad una riduzione dimensionale, mediante opportuna macinazione.
Secondo l'associazione la procedura di riduzione dimensionale del materiale da analizzare determinerebbe la formazione di quantità non trascurabili di frazioni fini in grado di poter alterare significativamente la distribuzione granulometrica del campione originale e di conseguenza il suo comportamento al test di lisciviazione. Sebbene questa possibile alterazione della rappresentatività del campione sia riconosciuta anche dalla norma UNI 12457-2, non viene tuttavia dettagliata in essa nessuna metodica standardizzata e specifica da seguire per la ricostruzione del campione a valle della macinazione, ma la citata norma si limita ad indicare solamente che "in nessun caso si deve macinare finemente il materiale".
Viene formulata la proposta di scartare la frazione fine che si genera artificiosamente dalla macinazione del materiale di prova con granulometrie inferiori a 500mm, riconducibili a sabbia, limo ed argille, ipotizzando altresì l'applicazione di alcune metodiche derivanti dalla prassi UNI/PdR 94:2020 o dalla norma UNI 1744-3:2003, per la ricostruzione del campione da sottoporre all'esecuzione del relativo test di cessione.
Viene quindi chiesto se sia ammesso interpretare il rinvio alla metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2 di cui al paragrafo d), d.2. dell'Allegato 1 del dm 27.09.2022 n.152, nel senso che in essa rientrino anche le procedure delle norme UNI/PdR 94:2020 e UNI 1744-3:2003, nei casi di materiali a granulometria ridotta.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta il quadro normativo e tecnico applicabile riassunto come segue:
- decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-lei; comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" ed in particolare l'Allegato 3 recante TEST DI CESSIONE - Principio del metodo
- UNI EN 12457-2:2004 Caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di confonnità per la liscitiazione di rifiuti granulari e di fa' righi - Parte 2: Prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/ solido di 10 l/ kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni)
- UNI EN 1744-3:2003 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Proarazione di eluati per dilavamento di aggregati.
- UNI/PdR 94:2020 Scoria nera da forno ad arco elettrico ( AF) - Metodo per /a preparazione del campione da sottoporre a prova di lisciviazione secondo la UNI EN 12457-2.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
In merito a quanto stabilito dalla norma UNI EN 1744-3 si rileva che la preparazione delle porzioni di prova per gli aggregati riciclati è descritta al punto 8 ove è riportato come ci si debba comportare nel caso in cui sia presente una componente di dimensione granulometrica superiore all'intervallo di riferimento. In particolare, la suddetta norma prende in considerazione la granulometria compresa tra 16 e 32 mm e per quanto riguarda la frazione maggiore di 32 mm è previsto che sia attuata una frantumazione cori un successivo isolamento della frazione compresa nell'intervallo 16/32 mm e l'aggiunta di tale frazione al campione in preparazione, in percentuale pari al contenuto inziale della componente superiore ai 32 mm. Una problematica che potrebbe derivare dall' applicazione di questa norma per le finalità del test di cessione è dovuta sia alle dimensioni delle particelle scelte, per le quali non sono previsti criteri analoghi a quelli stabiliti dalla nonna UNI EN 12457-2, sia al fatto che la norma UNI EN 1744-3 prevede, a differenza della norma UNI EN 12457-2, un rango specifico di misure dimensionali.
Nella norma UNI EN 1744-3 il campione è infatti costruito sulla frazione granulometrica compresa tra 16 e 32 mm mentre, nel caso della norma UNI EN 12457-2, il campione deve essere < 4 mm senza individuare una dimensione minima. In tal senso, la norma UNI EN 12547-2 riporta solo che "in nessun caso il materiale deve essere finemente macinato". Più nel dettaglio il punto 4.3.2 di tale norma 12547-2 prevede che la. macinazione debba essere effettuata solo qualora il materiale di dimensioni > 4 mm sia superiore al 5% in massa. Se si verifica tale condizione, tutta la frazione eccedente i 4 mm è sottoposta a macinazione, ma in nessun caso il materiale deve essere finemente macinato. Una volta macinata, tutta la frazione sottoposta a tale trattamento viene miscelata con la frazione <4 mm per costituire il campione di prova.
In merito a quanto stabilito dalla prassi di riferimento UNI/PdR 94:2020, questa "definisce un procedimento per la preparazione del campione da sottoporre a prora di lisciviazione secondo la norma UNI EN 12457-2, applicabile a campioni granulari di scoria nera da fo' rrio ad arco elettrico (EAF — Electric.. AreFurnace)".
Tale prassi stabilisce il limite dimensionale di riferimento "minimo" pari a 2 mm. Infatti, in base a quanto riportato al punto 7.1 la metodica consente di ottenere un campione di prova con una curva granulometrica che, per la frazione di campione con granulometria < 2 mm, corrisponde a quella del campione di laboratorio originariamente fornito, cioè prima della macinazione.
Anche in questo caso, la classe dimensionale > 4 mm, se presente in percentuale in peso > 5°/o, viene
sottoposta a macinazione e, successivamente si procede alla "ricomposizione del campione da destinare
alla prova di lisciviazione (secondo la norma UNI EN 12457-2) avendo cura di utilizzare per le frazioni inferiori a 2 mm la stessa abbondanza in massa (cioè percentuale in peso) presente nel campione di laboratorio originario e, per quanto riguarda la quota parte di campione restante da ricostituire, eli utilizzare la frazione di campione con granulometria compresa tra 2 mm e 4 mm (quella originaria unita a quella proveniente dalla frantumazione)".
Con riferimento alla eliminazione di alcune frazioni granulometriche a valle della macinazione cd all'individuazione di un limite dimensionale minimo, ovvero la proposta di codesta associazione di scartare la frazione fine, con granulometrie inferiori a 5001.1m, che si genera artificiosamente dalla macinazione del materiale di prova, va rilevato che le norme tecniche relative agli aggregati riciclati, riportate nella tabella 4 dell'allegato al DM 152/2022, individuano come "fine" la frazione di diametro < 0,063 mm. La norma UNI EN 13242 prevede per tale frazione un contenuto non superiore al 3%.
Il punto 4.1.4 della norma UNI EN 11531-1, sulle terre per sottofondi, stabilisce che la frazione passante al setaccio di diametro 0,063 mm deve essere < 15%.
La norma UNI EN 13450, sugli aggregati per massicciate ferroviarie, definisce particelle fini quelle con diametro <0,5 mm e come tini i materiali < 0,063 mm. In base al contenuto di fini della massicciata ferroviaria si parla di categoria di contenuto di tini A, B, C, ecc. La categoria di contenuto A deve avere una percentuale in peso <0,5%, la categoria C <1,5%, ecc.
Appare utile citare anche quanto disposto dalla norma UNI EN 933-10 che, tra le prove per la determinazione delle caratteristiche granulometriche degli aggregati, disciplina quelle specifiche per la valutazione dei tini (granulometria dei filler). La norma definisce come "aggregato filler" l'aggregato passante quasi completamente per le maglie di un setaccio con luce di 0,063 mm. Da ultimo si ricorda che anche nella classificazione granulometrica di suoli e sedimenti, secondo le classificazioni di Shepard (1954) e Nota (1958), la frazione fine è individuata come quella passante il setaccio di maglia da 0,063 mm.
Sempre con riferimento alla classe dimensionale dei materiali sottoposti a test di cessione si ritiene utile evidenziare che il paragrafo 8.2 della norma LINI EN 12457-2, relativo allo studio di validazione, al terzo trattino riporta specificatamente che "i rifiuti esaminati coprono tutte le dimensioni dei granuli alle quali si applica la prora di li.R.iviaione ili confòrmità: i rifiuti in polvere e i fanghi (da (l 11771 a circa 125 pm), i materiali a grana fine (da O mm a 4 mm) e i materiali a ,grana grossa (da O mm ad oltre 4 mm) dopo la necessaria rido ione delle dimensioni".
Da quanto sopra riportato si deduce che tutte le frazioni granulometriche devono essere prese in considerazione, a prescindere dalle specifiche dimensioni. Il concetto riportato al punto 4.3.2 della UNI EN 12457-2 "in nessun caso si deve macinare finemente il materiale" deve, quindi, essere letto nel senso che il processo di macinazione non ha lo scopo di ridurre finemente il materiale, ma serve solamente a ridurre le dimensioni dello stesso al di sotto dei 4 mm senza applicare un processo di macinazione eccessivamente spinto. La presenza di particelle fini derivanti dalla macinazione, pertanto, non identifica automaticamente il materiale come macinato finemente.
1,c considerazioni sopra riportare, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-septies del decreto) legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.